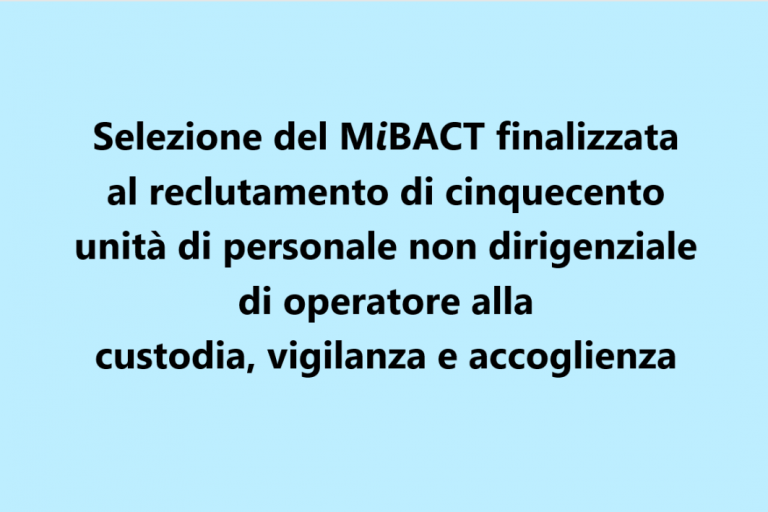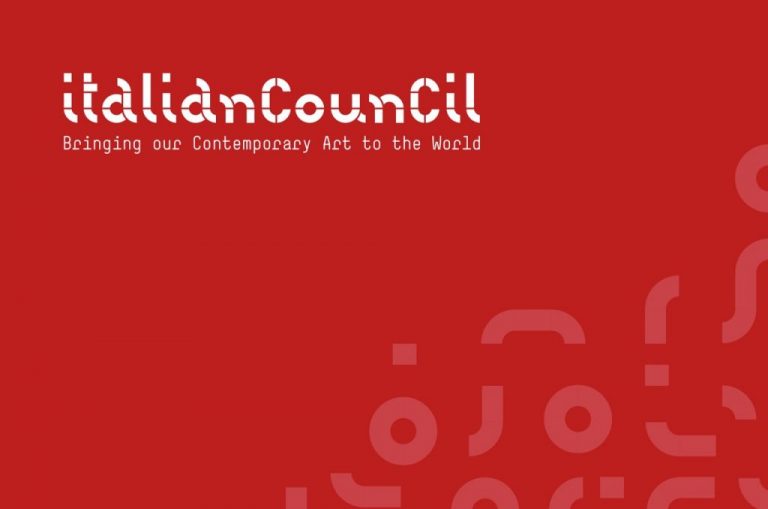SELEZIONE PUBBLICA PER INCARICHI PRESSO LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI DEL MiC
Si informano gli eventuali interessati che la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore del MiC ha indetto una procedura per il conferimento di incarichi di collaborazione per la figura professionale di Esperto catalogatore (46 posizioni). La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente tramite apposito modello, da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata. Pena nullità,…